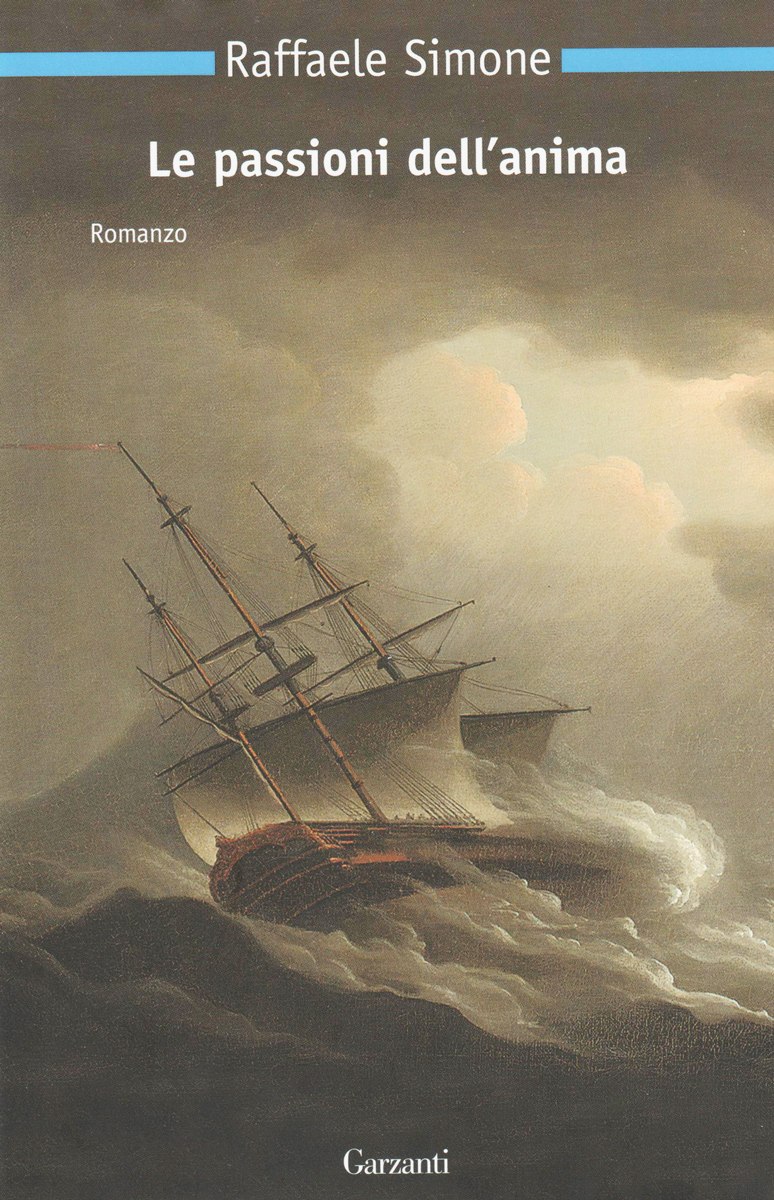Interverranno
Gennaro Carillo (storico del pensiero politico)
Vincenzo Cutolo (presidente EducaCi)
Conclude l’autore
Raffaele Simone
Valeria Pellecchia Pratelli leggerà alcuni brani del libro
Lunedì 30 gennaio 2012, ore 16.30
“Urban Center” del Comune di Milano
Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12
(MM1 – MM3 Duomo)
Dopo la pubblicazione di fondamentali saggi e studi, che lo avevano collocato fra i maggiori linguisti internazionali contemporanei, con Il paese del pressappoco (Garzanti, 2005) a sorpresa Raffaele Simone donò ai lettori un grande affresco critico sulla natura degli Italiani, sui loro difetti, sulla loro anarchica superficialità, rivelando notevoli capacità di analisi sociologica e politica e inserendosi a pieno titolo nella categoria letteraria dei moralisti moderni.
Il libro fu una fresca e lieta sorpresa nell’ambito della nostra saggistica, giacché contribuì ad arricchire magistralmente la letteratura che indagava sulla “peculiarità” degli abitanti del Belpaese.
Qualche anno dopo Simone diede alle stampe Il Mostro Mite (Garzanti, 2008), un assai intelligente saggio in cui lo scrittore analizzava le cause della crisi storica della Sinistra e dei progressisti – non soltanto in Italia – e l’avvolgente avanzata di un nuovo pervasivo Potere, quello della Neodestra, fondato sul consumismo di massa, sull’egoismo individualistico e su nuovi
Nel settembre 2004, terminato il mio settennio a Zurigo, chiesi e ottenni la Presidenza della media Tiepolo di Milano (dove conclusi i miei ultimi anni di servizio di ruolo). accattivanti modelli, che i partiti della Sinistra non avevano né saputo comprendere né contrastato (“Il Mostro Mite – ammoniva l’autore – è la faccia sorridente che il Leviatano ha assunto nell’era globale”).
Oggi Raffaele Simone torna a stupire i suoi lettori pubblicando non un altro saggio, ma un romanzo: il suo primo romanzo, Le passioni dell’anima (Garzanti, settembre 2011).
Occorre chiedersi subito se la nuova opera dello stimato scrittore debba organicamente essere collegata ai suoi precedenti saggi “politici” (ancorché realizzata in un diverso genere letterario), oppure se essa vada letta come una tradizionale “narrazione” riferita agli ultimi mesi di vita del filosofo francese René Descartes, originalmente costruita con gli artifici del romanzo storico.
Personalmente credo che, con “Le passioni dell’anima”, Simone intenda dare coerente continuità alla sua attenta analisi del Potere e dei meccanismi che impediscono alla società umana di migliorare se stessa mediante l’utilizzo della Saggezza e del Bene.
Il romanzo narra – come ho detto prima – gli ultimi mesi di vita di René Descartes, dal suo viaggio per mare verso il regno di Cristina di Svezia (ottobre 1649) fino alla morte, avvenuta a Stoccolma l’11 febbraio 1650. La narrazione – costruita non con i consueti canoni del romanzo, ma mediante
il sapiente montaggio di documenti storici originali, arricchiti da interpolazioni e lunghi brani vergati direttamente dallo scrittore – pone in evidenza una apparente, stridente contraddizione: quella tra il forte desiderio della regina di Svezia di ospitare a corte il più famoso filosofo del suo tempo e la condizione di Descartes – presso quella corte – di uomo “solo, afflitto, amareggiato,
inquieto, senza affetti… tenuto in ostaggio da un’ignota potenza”. Cristina di Svezia, vincitrice della Guerra dei Trent’anni, oltre ad aver dato al suo Paese un ricchissimo patrimonio d’arte (grazie alle numerose opere trafugate dai territori dei nemici sconfitti), si prefisse anche di elevare il livello
culturale sia della corte, sia della popolazione del regno. E chiamò a Stoccolma, per tale scopo, scrittori, artisti, eruditi, filosofi, per i cui compiti elargì prebende, privilegi e pensioni. Ella volle alla sua corte anche il maggiore filosofo del suo tempo, il francese Descartes, da cui intendeva
personalmente apprendere i valori del Sommo Bene.
Dopo l’arrivo del filosofo in Svezia ella scrisse a un’amica: “È finalmente nelle mie mani la preda più bella di tutte le mie guerre: il più grande filosofo d’Europa, il più saggio, il più nobile;… una mente così augusta mancava alla mia collezione”. Ma gli entusiastici intenti della regina svanirono all’improvviso. Il mutamento viene così descritto da Cristina, nel libro: “ È per un mio cambiamento interiore che vedendolo ho capito che tutto era svanito, come se il flusso tra noi si fosse gelato. Ho capito d’un tratto che mi basta averlo catturato e tenerlo qui come preda: quel che avevo dinanzi non era il grande filosofo di cui avevo ricercato la simpatia, ma una grossa lepre che s’era lasciata prendere”.
A Descartes tocca, quindi, la stessa sorte che toccò a Platone invitato in Sicilia dal tiranno di Siracusa e da questo accantonato e non utilizzato. Il Potere, vuole dirci Simone, mostra solo apparentemente di voler fare tesoro dei grandi spiriti. In realtà esso punta soltanto a imprigionarli e annullarli. Come nella Svezia della regina Cristina anche oggi, nella società politica
(in particolare in quella italiana), buona parte della “ intellighentsia” emergente – i cortigiani della “servitù volontaria” – è infatti asservita sterilmente al Potere mediante prebende, privilegi e favori.
La responsabilità di tale stato di cose, ammonisce Simone, è da addebitare tuttavia agli stessi filosofi e intellettuali.
Descartes, nel romanzo, attribuisce infatti alla Vanità la sua accettazione dell’invito a Stoccolma: accettazione che ha comportato il suo allontanamento dalla Francia e dall’Olanda, dagli amici, dal prestigio meritato e goduto, per trasferirsi in terre fredde e lontane, dove ha finito per trovare l’isolamento e la morte. Oltre alla Vanità, il romanzo analizza anche le varie e contrastanti passioni
da cui è agitata l’anima degli esseri umani: la Saggezza, la Speranza, il Timore, la Venerazione, l’Amore, la Pietà, la Gioia, l’Ammirazione, lo Sbalordimento, l’Inerzia, il Timore, l’Umiltà, il Favore, il Desiderio, la Devozione, l’Orgoglio, l’Odio, l’Invidia, la Gelosia, l’Ira, il Riso, la Tristezza, il Disgusto, la Riconoscenza, la Gloria, la Collera, il Rimpianto, la Derisione, il Pentimento, la Soddisfazione, l’Allegria, l’Ironia, l’Indignazione, la Paura, la Disperazione, la Viltà, il Coraggio.
E lo fa non solo tramite citazioni dal testo cartesiano Le passioni dell’anima (riprese in forma di epigrafi), ma anche attraverso ragionamenti attribuiti ai personaggi del libro. Qualche esempio: 1) “La Speranza è una disposizione dell’anima a convincersi che accadrà quel che essa desidera; è causata da un particolare moto
degli spiriti, cioè da quello della Gioia e del Desiderio messi insieme”; 2) “l’Ironia è uno strumento della mente… con cui costruire e consolidare ripari alla nostra fragilità. Aiuta a cogliere il comico nelle cose più solenni e gravi; a rifare il verso ai potenti e agli stupidi, sapendo che le due categorie spesso coincidono; a ridere di noi stessi…; a scovare il lato divertente nelle cose drammatiche e quello serio nelle comiche – e così, insomma, a tenerci alla larga da gran parte di quel che ci potrebbe far male”; 3) “la Saggezza è principalmente utile per il fatto che insegna a renderci talmente padroni delle passioni e a dominarle con tanta maestria, che i mali che esse causano sono
del tutto sopportabili, e se ne può perfino trarre qualche gioia”.
Il romanzo è di lettura assai piacevole anche per la sua grande eleganza linguistica. Nel montare gli originali “capitoli” (costituiti tutti da lettere, rapporti, resoconti, pagine di diario dei personaggi del libro) Simone fa uso di un registro espressivo che ridona il fascino della lingua francese colta del
XVII secolo (dove brillano soprattutto la ratio e il nitore del periodare di René Descartes, le cui “pagine di diario” – inesistenti come documenti di archivio – sono magistralmente create dalla sapienza linguistica dello scrittore).
Le passioni dell’anima è un gran bel romanzo: originale, attuale, problematico ed avvincente. Consiglio a tutti di leggerlo: sia a chi crede che il Potere non sia l’unico obiettivo della politica, sia soprattutto a coloro cui risulta utile analizzare le proprie passioni, per comprendere meglio il senso della vita e migliorare se stessi.
( EducaCi online, febbraio 2005 )
NOTA – Il libro di Raffaele Simone fu presentato a Milano il 30 gennaio 2012 (nella sede comunale dell’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II) dal presidente di “EducaCi” Vincenzo Cutolo, dall’autore e dal prof. Gennaro Carillo dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.
La presentazione fu organizzata dall’Associazione “EducaCi” e dall’editore Garzanti. Alcuni brani del libro furono letti dalla prof. Valeria Pellecchia Pratelli.
Gli interventi a milano sul romanzo di Raffaele Simone
Valeria Pellecchia Pratelli legge, dal romanzo di Simone, le pagine 31-32
(Descartes rievoca il suo periglioso viaggio per mare, dall’Olanda a Stoccolma).
L’INTRODUZIONE DI VINCENZO CUTOLO
Saluto il cortese pubblico e ringrazio il Comune di Milano (nella persona del dott. Alfredo Spaggiari) per l’ospitalità offerta all’iniziativa culturale di EducaCi. Ringrazio anche il prof. Raffaele Simone, venuto appositamente da Roma dove insegna all’Università di Roma Tre, e il prof. Gennaro Carillo venuto anche lui appositamente da Napoli dove insegna all’Università Suor Orsola Benincasa.
La nostra associazione, che opera a Milano dal 2005, ha finora realizzato molte iniziative di impegno civile: l’introduzione dell’Educazione civile in alcune scuole, la promozione dello studio della Costituzione, alcune conferenze, uno spettacolo di teatro civile e la presentazione del libro “Nel labirinto degli dei / Storie di mafia e di antimafia” del magistrato Antonio Ingroia. Questa sera essa presenta il primo romanzo pubblicato da Raffaele Simone, “Le passioni dell’anima” edito da Garzanti, sia perché il Prof. Simone è socio onorario di EducaCi, sia perché – a nostro avviso – questo romanzo è un grande e prezioso libro, di eccezionale valore culturale ed educativo.
Al fine di entrare subito nell’atmosfera del libro, abbiamo preferito iniziare l’incontro con la lettura di una delle sue prime pagine, lettura che abbiamo appena ascoltato dalla bella voce della professoressa Valeria Pellecchia Pratelli, fondatrice di EducaCi. Da questa prima lettura possiamo rilevare che il libro di Raffaele Simone inizia con un elemento narrativo topico di ogni narrazione: un viaggio. Nella narrativa e in poesia il viaggio implica sempre un distacco, una speranza verso il futuro, la preoccupazione di un rischio.
A compiere all’inizio il viaggio, nel libro di Simone, è il filosofo francese René Descartes (in italiano Cartesio), che dall’Olanda nel 1649 raggiunge in nave la Svezia, invitato a Stoccolma dalla giovanissima regina Cristina. Descartes lascia volontariamente l’Olanda (il Paese europeo in cui aveva preferito stabilirsi in virtù della maggiore libertà e tolleranza che esso gli offriva rispetto alla Francia della prima metà del XVII secolo), per accogliere il pressante invito venutogli da una regina che è la vincitrice della Guerra dei Trent’Anni, la “Guerra Interminabile”. Consapevole dei rischi del viaggio, Descartes lascia tutto – amicizie, onori, affetti – per poter meditare sul Sommo Bene in compagnia di una regina che, in quegli anni, è impegnata per un nobile scopo politico: quello di elevare il livello culturale e civile del proprio Paese mediante la presenza, alla sua corte, dei maggiori artisti e intellettuali dell’Europa del tempo (ai quali ella offre ospitalità con onorificenze, pensioni e prebende). Isolato, però, da tutti ( per volere della stessa regina, che lo considera soltanto una sua “preda”), Descartes muore dopo pochi mesi in un ambiente ostile, caratterizzato da intrighi e invidie, forse vittima di un omicidio per veleno.
Simone era noto, finora, per i suoi fondamentali testi di Linguistica e per alcuni saggi che ne avevano rivelato le notevoli capacità di analisi politico-culturale (soprattutto “Il paese del pressappoco / Illazioni sull’Italia che non va” e “Il Mostro Mite / Perché l’Occidente non va a sinistra”, quest’ultimo da poco tradotto e pubblicato anche in Spagna). Ora egli si ripresenta ai lettori con un romanzo, il suo primo romanzo, la cui particolare e originale stesura conferma la tesi di un grande semiologo di origini russe, Michail Bachtin, secondo il quale il romanzo – fra tutti i generi letterari –è quello più aperto alla evoluzione e alla sperimentazione (Bachtin sostiene addirittura che lo studio del romanzo va equiparato a quello delle lingue vive, mentre l’approccio agli altri generi letterari va paragonato allo studio delle lingue morte).
Nell’avviare la narrazione, Simone evita il logoro e tradizionale artificio del cosiddetto “manoscritto ritrovato” (artificio a più riprese variamente utilizzato dagli autori di romanzi storici o neostorici: si pensi al Manzoni dei “Promessi Sposi”, al Walter Scott di “Ivanhoe”, al Cervantes di “Don Chisciotte”, al Hawthorne de “La lettera scarlatta” e, più vicino a noi, all’Umberto Eco de “Il nome della rosa”). Egli costruisce inoltre la vicenda narrata utilizzando una particolare e originale forma di “montaggio”, che era finora inedita nella storia del romanzo.
In “Le passioni dell’anima” la narrazione dei fatti e delle vicende avviene, infatti, tramite il montaggio e l’assemblaggio di numerosi documenti apparentemente autentici, in tutto e per tutto simili a quelli che potremmo trovare – tradotti in buon italiano – negli archivi storici o nelle pubbliche biblioteche (lettere, relazioni, pagine di diario, etc.). Anche se l’autore, nella nota “Al lettore” dell’ultima pagina del libro, confessa che il suo romanzo mescola insieme documenti autentici e documenti apocrifi (cioè scritti personalmente da lui), è mia convinta opinione che i documenti di cui si compone “Le passioni dell’anima” siano autentici solo in piccolissima parte. E che in massima parte essi siano stati, invece, elaborati ex novo dallo scrittore Raffaele Simone, in una lingua e in uno stile che restituiscono miracolosamente – grazie alla grande abilità del nostro maggiore linguista – il nitore e la bellezza della lingua cartesiana del tempo, da lui recuperata e rigenerata.
Come narratore Simone riesce, inoltre, proprio grazie alla originale struttura del montaggio cronologico dei documenti, a raccontare la vicenda senza in alcun modo apparire nelle vesti di autore del testo. In ciò realizzando quell’obiettivo letterario dell’“opera che si fa da sé”, che fu la grande aspirazione del naturalismo e del verismo europei, i cui scrittori mirarono alla totale “oggettività” dell’opera d’arte. Si pensi al Verga de “I Malavoglia”, romanzo in cui sembra che a narrare non sia lo scrittore-autore, ma il “popolo” con la sua lingua e la sua coralità (in una pagina di quel romanzo, ad esempio, la morte di Bastianazzo – il figlio di padron ‘Ntoni perito in un naufragio – viene non “raccontata o descritta”, ma oggettivamente “rappresentata” alla vedova mediante la semplice posizione delle braccia delle vicine sul grembo; e inoltre in tutto il romanzo sono presenti un linguaggio semplice, spoglio, intervallato da modi di dire popolari, e una sintassi elementare, racchiusa in una struttura non “colta”, dialettale).
Nel suo romanzo Simone usa quindi, anche lui volutamente, la tecnica della “’impersonalità”, lasciando che il centro della narrazione siano i fatti (“nudi e schietti”, come sosteneva il Verga) , non le valutazioni dell’autore. Verga aveva anche affermato che il racconto è un ”documento umano”, in cui “la mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile e l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé”. Il romanzo di Simone sembra, a ben guardare, collegarsi perfettamente a quel tipo di teoria letteraria. Esso è, infatti, in senso assoluto, un vero e proprio “documento umano”, giacché è costituito – come ho detto prima – esclusivamente di “documenti”. Documenti che al lettore appaiono del tutto autentici, scritti personalmente dai protagonisti della narrazione.
Ed è proprio qui la grande abilità del romanziere Simone. Qui la sua assoluta originalità. Se, infatti, il romanzo che deve basarsi sull’obiettività è da considerarsi riuscito quando ha la naturalezza della realtà (e quando il suo autore dimostra di essere al di fuori della vicenda che narra), noi possiamo a buon diritto dire che Simone è perfettamente riuscito nell’intento di donarci un romanzo che sembra essersi “fatto da sé”.
Ma “Le passioni dell’anima” non è solo un romanzo “fatto da sé”. Esso è anche un “romanzo-specchio” (nel significato che Stendhal attribuiva a questo genere letterario), in cui Simone rivive personalmente la vita dei personaggi – soprattutto quella del protagonista Descartes – con mimetismo interiore e con la ricreazione di un mondo superiore nel quale poter trovare rifugio.
L’ambiente in cui è collocato il romanzo è un’epoca del passato, il Seicento. “Le passioni dell’anima” è, quindi, un romanzo storico. Nella letteratura, non solo europea, la storia ha ispirato spesso gli autori di romanzi. Nell’Ottocento essa ha, infatti, caratterizzato la rievocazione del Medioevo come epopea cavalleresca (ad esempio nel romanzo “Ivanhoe” di Walter Scott) o come nascita delle nazionalità e riscatto dei popoli (ad esempio nei romanzi “La Battaglia di Benevento” di Francesco Maria Guerrazzi ed “Ettore Fieramosca” di Massimo D’azeglio).
Ma essa ha anche ispirato una rievocazione del Medioevo in cui l’autore potesse ”giocare” sperimentalmente con le mescolanze linguistiche e con gli strumenti del romanzo gotico, della detective story e della metafora del presente (si veda, ad esempio, il romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa”, pubblicato alcuni anni fa, in cui l’assistente del protagonista-indagatore Guglielmo di Baskerville si chiama Adso, nome che ricorda Watson l’assistente di Sherlock Holmes dei romanzi di Conan Doyle, e in cui l’autore – tramite gli scontri tra le diverse posizioni religiose dei monaci – ammicca anche alle divergenze politiche degli extraparlamentari italiani post-sessantottini).
Inoltre il passato storico, quale riflesso di un’oppressione straniera da cui tentare di liberarsi, è stato rievocato anche da Alessandro Manzoni, nel romanzo “I Promessi Sposi”. Lì il Seicento rievocato era quello della dominazione spagnola; e le vicende narrate erano – oltre che espressione di una particolare dimensione religiosa e di un innovativo riscatto degli umili – anche la velata metafora della dominazione austriaca contro cui lottavano i patrioti del Risorgimento.
La rievocazione del passato, in letteratura, è stata però anche la ricerca di un “luogo dell’anima”. La Grecia classica, ad esempio, nell’Ottocento venne vagheggiata da numerosi scrittori, nel tentativo ideale di uscire da una realtà caratterizzata dalla “morte della bellezza” (a causa delle guerre sanguinose seguite alla Rivoluzione francese, delle libertà promesse e successivamente tradite, delle delusioni politiche).
Alla Grecia antica si rivolsero il poeta inglese John Keats, i Parnassiani francesi, i nostri poeti Ugo Foscolo (deluso dal Trattato di Campoformio, con cui Napoleone cedette all’Austria la Repubblica di Venezia) e Giosuè Carducci (con le “Primavere elleniche”), e soprattutto il tedesco Friedrich Hoelderlin con il romanzo “Iperione”, in cui il personaggio di Diotima incarnava aspirazioni e ideali di serena armonia e di universale libertà.
Col suo romanzo, anche Raffaele Simone si rivolge a un passato storico:che è quello del Seicento, ma del Seicento della filosofia cartesiana. Un Seicento che, per lui e per noi lettori, diventa anche un particolare “luogo dell’anima”.
Simone legge da anni – mediante acuti saggi ed articoli caratterizzati da lucidissima capacità critica – una realtà sociale e politica (non solo italiana) sempre meno esaltante e sempre più degradata. Qualche critico, per questo, lo ha definito “descrittore di catastrofi”. Egli si definisce, però, “marxista-leopardista”, volendo con ciò intendere che crede ancora nella lotta contro i conflitti sociali e nel miglioramento della morale dell’uomo, ancorché con una profonda vena di scetticismo.
Il Descartes del suo romanzo è il prototipo dell’intellettuale illuminista del secolo succeduto al Seicento (è questa la lettura che del protagonista del libro di Simone dà il critico Giulio Ferroni). Come faranno poi Voltaire ed altri grandi spiriti dell’Illuminismo, Descartes avvia per primo il sogno dell’intellettuale che tenta di donare saggezza a chi detiene e gestisce il Potere. Tuttavia la sua “missione” di contribuire al raggiungimento della Saggezza e del Bene non gli riesce, giacché il Potere (nel suo caso, la regina di Svezia) lo considera solo una personale “preda”, non uno spirito da cui farsi consigliare o guidare.
A Descartes tocca, in fondo, la stessa amara sorte che toccò nella Grecia antica a Platone, invitato e poi malamente accantonato dal tiranno di Siracusa. E’ il destino anche dell’intellettuale di oggi, sembra dirci Simone. E lo dice al lettore che è in condizioni di leggere anche al di là della vicenda narrata.
Uno scrittore italiano scomparso pochi anni fa, il narratore Michele Prisco (nato a Torre Annunziata, paese natale anche di Tullio de Mauro, maestro di Raffaele Simone, ma vissuto per anni a Milano, dove fu critico teatrale del “Corriere della Sera”), divideva il lettore dei romanzi in tre categorie:
- a) il “lettore-spettatore”, quello dell’Ottocento, che “osservava” da lontano le vicende narrate dallo scrittore;
- b) il “lettore-collaboratore”, quello del Novecento, che “aiutava” lo scrittore ad esprimere la profondità del suo io tramite il monologo interiore e il flusso di memoria, quasi ponendosi per lui come “sponda”;
- c) il “lettore-persona da coinvolgere nella complessità della vita”, quello di oggi, che viene immerso dallo scrittore nei misteri dell’animo umano.
Il romanzo di Simone coinvolge il lettore nei grandi sentimenti e nelle grandi passioni dell’anima, mediante una vicenda storica ricreata con sapienza linguistica, sperimentale peculiarità e personale rispecchiamento. In esso lo scrittore dà anche coerente continuità alla sua attenta analisi del Potere e dei meccanismi che impediscono alla società umana di migliorare se stessa mediante l’utilizzo della Saggezza e del Bene. Il Potere, egli sembra dire, mostra solo apparentemente di voler fare tesoro dei grandi spiriti . In realtà esso punta soltanto a imprigionarli e annullarli. E, come nella Svezia della regina Cristina, anche oggi nella società politica (in particolare in quella italiana) buona parte della “ intellighentsia” emergente – i cortigiani della “servitù volontaria” – è asservita sterilmente al Potere mediante prebende, privilegi e favori.
La responsabilità di tale stato di cose, ammonisce velatamente Simone, è da addebitare tuttavia anche ai filosofi e agli intellettuali. Descartes, nel romanzo, attribuisce infatti alla Vanità la sua accettazione dell’invito a Stoccolma: accettazione che ha comportato il suo allontanamento dalla Francia e dall’Olanda, dagli amici, dal prestigio meritato e goduto, per trasferirsi in terre fredde e lontane, dove si è ritrovato “solo, afflitto, amareggiato, inquieto, senza affetti … tenuto in ostaggio da un’ignota potenza”, che lo ha infine condotto prematuramente alla morte.
In una sua bella poesia Aldo Palazzeschi si chiedeva “perché scrive lo scrittore?”. E, scartando le risposte riferite a “un mestiere come un altro”, all’“amore per la parola” e alla “vanità”, egli finiva per affermare che lo scrittore scrive “per tendere una mano nel buio / con la speranza che qualcuno la stringerà”. Io credo che la mano tesa da Raffaele Simone, col suo romanzo “Le passioni dell’anima”, sarà afferrata e stretta da numerosi lettori.
Valeria Pellecchia Pratelli legge, dal romanzo di Simone, le pagine 112-115
(Cristina di Svezia parla della sua “preda” Cartesio e dei dotti da lei invitati a corte)
L’INTERVENTO DI GENNARO CARILLO
Per molti versi, Le passioni dell’anima è un libro cifrato, un libro a chiave, ma anche un libro fatto di libri, come si evince fin dal titolo, che ripete quello dell’ultima opera di Descartes, che ricevette le prime copie dell’edizione elzeviriana negli ultimi mesi del 1649, dunque poco prima di morire. Tuttavia, mentre un altro romanzo dal titolo quasi uguale, Trattato delle passioni dell’anima, del portoghese Antònio Lobo Antunes, non ha niente a che fare con Cartesio (è un’impervia sperimentazione, il racconto di un interrogatorio di un giudice istruttore a un terrorista), quello di Raffaele Simone è proprio un romanzo su Descartes, in alcune pagine è un romanzo di Descartes, perché attinge a fonti cartesiane: l’epistolario, in particolare, ma anche le epigrafi che fanno da soglie a ciascun capitolo del percorso, tratte dagli articoli de Le passioni dell’anima.
Comincerei da poscritto Al lettore, che contiene un’allusione a un pensatore definito da Simone “non meno oscuro che fascinoso”, il quale pare ambisse a scrivere un’opera composta di sole citazioni. Questo scrittore è Walter Benjamin. Ebbene, nella sua accademicamente sfortunata dissertazione sull’Origine del Trauerspiel tedesco, Benjamin delinea i tre tipi, le tre maschere di carattere principali, sebbene non esclusive, del dramma barocco: il martire, il tiranno, l’intrigante. Questa triade ricorre, a mio modo di vedere, anche nel romanzo di Simone (Descartes: il martire; Cristina di Svezia: il tiranno; i cortigiani: l’intrigante), romanzo che dunque può essere interpretato anche come un dramma barocco. Anzi: come un dramma nel quale Descartes si misura con e contro il Barocco. Vorrei essere più preciso: Simone integra lo schema di base del dramma barocco con figure ed elementi propri di altre tradizioni letterarie: il romanzo epistolare, il romanzo francese della mondanità, la ricostruzione di un monde, di un milieu, di un ambiente di vita in cui i soggetti agiscono, come ha scritto Guido Mazzoni nella sua recentissima Teoria del romanzo, “in un regime di latente competizione simbolica”.
Ma su questo tornerò più tardi.
Le passioni dell’anima di Raffaele Simone, come si è già detto, non è un romanzo ‘di montaggio’, di sole citazioni. I materiali preesistenti potevano solo costituire l’ossatura, della storia: per fare di questi materiali romanzo, occorreva, scrive Simone, colmare lacune, vuoti. Ecco perché questo è un romanzo d’invenzione, nel duplice senso del termine: da una parte, invenzione come inventio, come heuresis in funzione della dispositio, del riordino dei documenti, delle fonti, sulla base di un disegno compositivo; dall’altra, invenzione come creazione, costruzione, racconto di finzione. Per costruire un racconto credibile, che si amalgamasse senza crepe con le fonti, Simone ha dovuto, né più né meno, che riprodurre, mimeticamente, una lingua e uno stile, prima ancora che un umore, un mondo, un secolo, il Seicento (penso che il romanzo avrebbe potuto avere per titolo Seicento, riecheggiando Bernardo Bertolucci).
Una lingua e uno stile nei quali Hippolyte Taine vide i contrassegni di quello “spirito classico” che si afferma in Francia tra Cinque e Ottocento, tra Montaigne e Balzac: una lingua che è l’esito, sono parole di Taine, di una “raschiatura” del vocabolario, di un’“epurazione” che persegue gli ideali dell’esattezza, della chiarezza, dell’urbanità, la perfezione del “buon discorso” che trasforma opere non letterarie ma di metafisica o di scienza, come quelle di Descartes, in “belle opere d’arte”, in modelli di eloquenza. Con umiltà, Simone chiude il poscritto dicendo che un lettore esperto riuscirebbe a distinguere senza difficoltà l’originale dall’apocrifo. Non credo, invece, che questa distinzione risulti sempre agevole: anzi, a volte, si ha l’impressione che Simone ricorra ad anacronismi volutamente scoperti proprio per interrompere l’illusione efficacissima della trascrizione (che è invece riscrittura, appropriazione di Descartes), per rivelare al lettore quelle che una grande francesista, traduttrice di Montaigne, Fausta Garavini, chiamava le “imbastiture” del testo, quelle imbastiture, quegli artifici che il principio primo dell’illusione romanzesca imporrebbe di occultare. Faccio alcuni esempi:
(a) Descartes richiama nel 1649 (nella lettera apocrifa a Elisabetta) un pensiero che Pascal formulerà nelle Pensées, che cominciò a scrivere nel 1657 e videro la luce, postume, solo nel 1670: ma i due s’incontrarono due volte a Parigi, nel settembre 1647, dunque Descartes potrebbe aver appreso dalla viva voce di Pascal (Simone fa dire a Descartes: “Pascal…sostiene” o “ritiene Pascal”) quello che poi sarebbe stato divulgato dopo la morte di entrambi[1] ;
(b) il rivale di Descartes Antonio Damasio è un neurologo portoghese che ha sì pubblicato L’errore di Cartesio, ma nel 1994, non a metà del XVII secolo, opponendo il monismo ontologico di Spinoza al dualismo cartesiano di res cogitans e res extensa;
(c) la formula “a cenar teco” cita il Don Giovanni di Lorenzo Da Ponte per Mozart, che va in scena nel 1787.
Il primo intervento del tutto apocrifo di Simone è la pagina di diario che Descartes redige a bordo dell’Espérance, il 5 settembre 1649. Il filosofo lascia la terraferma, l’Olanda, per raggiungere la Svezia, su invito della regina Cristina. Ora: i viaggi, tra i filosofi, si sprecano ed è troppo forte, ma credo non oziosa, la tentazione di confrontare il viaggio di Descartes con i tre viaggi, esemplari, di Platone a Siracusa: una prima volta, nel 388/387, alla corte del tiranno Dionisio I; una seconda, vent’anni dopo, nel 366/365, alla corte di Dionisio II; una terza, infine, nel 361. In comune, i viaggi di Platone e quello di Descartes hanno l’ospite, che è un autocrate (un tiranno e una regina) e l’esito, che è sempre fallimentare. Ma, al di là di queste somiglianze, la differenza è radicale: se Platone, come si apprende dalla Lettera Settima, è mosso da una vocazione politica, è sollecitato dalla possibilità di sottoporre a una verifica pratica le proprie teorie peri nomon e peri politeias (sulle leggi e sulla costituzione politica), persuadendo un solo uomo, dotato della massima potenza politica e ben disposto verso l’insegnamento filosofico, Descartes non tradisce alcuna vocazione politica. Anzi, come si rileva non solo dalla critica dei riformatori nella parte sesta del Discorso sul metodo ma anche dalla lettera del maggio 1646 a Elisabetta del Palatinato, la politica appare a Descartes come un ambito nel quale l’esperienza si rivela molto più produttiva della ragione e soprattutto come una sfera dominata dalla Fortuna, per molti versi sottratta al libero arbitrio. E nella lettera a Elisabetta del primo settembre 1645 Descartes addirittura sostiene che “le seduzioni della corte […] impediscono di vivere da filosofi più delle disgrazie medesime”. Perché dunque rischiare la morte per acqua andando in Svezia, per giunta proprio a corte? La chiave è in una lettera, apocrifa anch’essa, che Simone finge dettata da Descartes, ormai morente, al valletto Schlueter. Ed è una risposta che rinvia, ancora una volta, a Pascal, alla sezione dei Pensieri dedicata alla vanità: Descartes parte per “vivere […] una vita immaginaria”, per vivere “nel concetto”, nella rappresentazione di un potente da compiacere e cui sottomettersi volontariamente. Ma allorché si dichiara vinto dalla vanità e dalla bramosia di sottomissione, Descartes confessa implicitamente il fallimento, molto “umano”, della propria strategia di maîtrise delle passioni, il cedimento della volontà all’impulso, l’incapacità di ricondurre a una giusta misura i beni che la vanità fa apparire molto più grandi di quanto in realtà non siano (art. 138 delle Passioni dell’anima, che sarà ripreso puntualmente da Pascal in Pensieri, 108 [127].
[1] Il romanziere non è tenuto ad assumere il tempo come un vincolo inderogabile. Il Seicento è assunto da Simone come un grande piano di scorrimento sul quale muoversi – e disporre situazioni e personaggi – a proprio piacimento, anche invertendo l’ordine del tempo: licenza consentita al solo scrittore, non allo storico della filosofia. Scegliendo la finzione romanzesca, Simone dismette l’abito scientifico del filosofo del linguaggio (e dello storico della filosofia) per concedersi la libertà felice dello scrittore.
E’ un contrappasso tragico, quello allestito da Simone: Descartes cade vittima della vanità, passione barocca per eccellenza, cade vittima di quella stessa macchina barocca, di quella grande lente deformante che aveva avversato per tutta la vita e dai cui inganni percettivi era sempre riuscito a guardarsi (conservando, persino in sogno, un’espressione perplessa e dubitativa, come annota nel suo diario apocrifo Mme Chanut che ama Descartes di un amore carnale e impossibile).
Torno allora su un tema, il rapporto di Descartes con il Barocco, al quale accennavo all’inizio. Il viaggio fatale a Stoccolma è un contrappasso perché costituisce una deviazione, una digressione dalla via diritta, abbandonata “per futili motivi” (DM), che induce il filosofo a smarrirsi in una amethodos hyle, per dirla con Sesto empirico, in una selva (la foresta del Discorso sul metodo) senza sentieri e senza uscita, quale si rivelerà essere la corte di Cristina. Qui Descartes cade prigioniero di un intrico barocco nel quale “ogni cosa è ruotata”, tutto è obliquo e quello che appare dissimula una realtà inconfessabile. Nel racconto di Simone, la corte diventa un congegno, una macchina, di duplicazione del reale. Metafora superba della ragion di Stato e dell’ossessione per il ‘segreto’, il palazzo reale nasconde un sistema di dotti acustici, fatto impiantare da Gustavo Adolfo, che dovrebbe consentire a una corte paranoica di intercettare tutte le conversazioni e di prevenire possibili cospirazioni e che invece finisce per indurre tutti coloro che ne sono a conoscenza o a bisbigliare o a cifrare i propri discorsi.
Di conseguenza, scrive Simone: “Il vero e il falso si confondono sino a rendere incerto, perplesso e folle chi vi si trova in mezzo e fino a che l’idea stessa di verità si dissolve. Sanno, coloro che parlano così, qual è la verità delle cose? O si trastullano tutti in un sinistro gioco di specchi?” (dal diario di Descartes, p. 211).
Proiettato dal deserto, luogo simbolico di quel ritiro dal mondo, di quello scioglimento dei legami anche sentimentali che costituisce la condizione ottimale della meditazione, sulla scena della corte, Descartes denota tutta la pochezza della propria attrezzatura, la difficoltà di corteggiare, nell’accezione castiglionesca del termine, di stare a corte con scioltezza, di adattarsi con disinvoltura alle circostanze. Tant’è che il suo impatto con Cristina è tutto una gaffe: prima si fa sorprendere a sgranocchiare biscotti, goffo, infreddolito, in un’altra occasione le risponde con un eccesso di franchezza, manifestando la propria indifferenza verso i classici a una regina che invece li adora, specie gli stoici (Epitteto, Seneca, Marco Aurelio), e ne colleziona le edizioni dei migliori filologi moderni, come Casaubon e Gronovius. Una regina incostante che, a differenza della principessa palatina Elisabetta, non ha tuttavia una vera propensione alla filosofia moderna: né direttore spirituale, né istitutore, né interlocutore, ma “preda”, Cartesio la delude subito e finisce per diventare nient’altro che il pezzo vivente, anzi l’animale morente, di una tipica Wunderkammer barocca, collezione di curiosità, di oggetti esotici.
La storia del viaggio in Svezia diventa allora, nel romanzo di Simone, la storia di un rigetto, di una fioritura mancata perché impossibile: la filosofia, in un contesto refrattario, un allotrion ethos (Platone, Repubblica, VI, 497b7), resta un seme estraneo, uno xenikon sperma (497b4), destinato a morire perché incongruo, fuori luogo. Oppure, da venator veritatis, da cacciatore della verità, regredisce a preda, a caccia, per dirla in termini bruniani.
E’ la stessa sorte toccata al leone che l’imperatore Rodolfo volle a Stoccolma e morì triste perché inadatto a quelle latitudini. Un animale la cui fine prefigura quella di Descartes. Leggiamo un poscritto del diario dove Simone presenta un Descartes già consapevole del fallimento e della fine, pervaso di quella melanconia (la bile nera) che avrebbe voluto curare in Elisabetta, la grande melanconica e che invece, a detta del pittore Machado, lo condurrà a una morte molto letteraria, la stessa di Chisciotte: “La storia del leone che, portato a Stoccolma, è morto di tristezza m’ha colpito molto. Mi sento infatti proprio come lui: i denti indolenziti dal freddo, le ossa slogate dai sobbalzi, preda di guerra, sballottato fuori dalla mia terra passando da un padrone all’altro, in cattività e spaesato, maldestro e privo di scopo, trasformato in cimelio nelle collezioni di stranezze”.
Non è un caso, allora, che un ruolo importante giochi nel romanzo Machado e, attraverso Machado, Cervantes. Il Chisciotte è il romanzo inaugurale della modernità, il romanzo che inaugura la forma romanzo. Le passioni dell’anima è anche la storia dell’incontro, nel segno della melancolia, della filosofia con il romanzo, del più moderno dei filosofi con il più moderno dei romanzieri.
Vorrei chiudere con una notazione sul romanzesco di questo romanzo, per usare l’espressione di Romano Luperini. Che la fine di Descartes sia nota non significa affatto che in questo romanzo non ci sia storia, che non ci sia sviluppo narrativo, trama, plot, come invece sostiene Luperini. La maestria di Simone sta proprio nel disporre gli eventi, reali o immaginari, in modo che ognuno si avvicini alla fine, che ogni segno sia la premonizione, il memento di quella fine, come nelle rappresentazioni pittoriche barocche della caducità in cui anche le immagini di maggior pienezza saranno ‘contraddette’ da quello che Gianfranco Contini chiamava “stabile contrappunto tanatologico”: un teschio, delle ossa, che agiscano come un memento e suscitino horror vacui nello spettatore.
Ecco allora la partenza assumere il senso di una vera e propria dipartita, di un viaggio senza ritorno, e la navigazione, disseminata com’è di chimere, di illusioni visive e uditive, quello di una perdita dell’ubi consistam, scrive Simone. Di un ubi consistam, di un ancoraggio saldo al reale che il Descartes di questa storia non riacquisterà più.
Non solo: man mano che i segni convergono, che l’epilogo della vicenda prende corpo, con Descartes ancora vivo ma già postumo, già reliquia (altro motivo barocco), Simone moltiplica le interpretazioni possibili circa le cause, non necessariamente naturali, della morte del filosofo, e i moventi dei potenziali mandanti dell’ipotetico omicidio: che è anche tecnica, questa, propria del romanzo giallo.
Il romanziere non è tenuto ad assumere il tempo come un vincolo inderogabile. Il Seicento è assunto da Simone come un grande piano di scorrimento sul quale muoversi – e disporre situazioni e personaggi – a proprio piacimento, anche invertendo l’ordine del tempo: licenza consentita al solo scrittore, non allo storico della filosofia. Scegliendo la finzione romanzesca, Simone dismette l’abito scientifico del filosofo del linguaggio (e dello storico della filosofia) per concedersi la libertà felice dello scrittore.
Valeria Pellecchia Pratelli legge, dal romanzo di Simone, le pagine 132-134
(Descartes racconta un suo sogno erotico)
L’INTERVENTO DI RAFFAELE SIMONE
Voglio dire anzitutto che, malgrado le bellissime parole che sono state pronunciate attorno a questo tavolo a proposito del mio romanzo, io sono un dilettante o forse meglio un esordiente attardato. Quindi sono ben consapevole dei limiti della mia operazione. Sono però anche uno che da anni cerca di torcere il collo allo stile accademico e il mio romanzo nasce essenzialmente da quel desiderio: dare uno strappo definitivo, nella mia biografia, allo stile accademico e alle sue rigidità e prendermi finalmente alcune libertà interiori.
La storia che il romanzo sviluppa – che mi girava per la testa da un pezzo — mi è balzata nuovamente in testa a seguito di un episodio curioso che non posso raccontare. SI tratta di questo: René Descartes, dopo aver resistito per anni agli inviti della Regina di Svezia, che vuole lezioni di filosofia dalla viva voce di lui, si arrende e parte. Forse è la vanità che lo spinge. A Stoccolma arriva dopo un pericoloso viaggio per mare. Scopre sul posto che la regina gli ha fissato le lezioni per le cinque della mattina (a lui dormiglione!) e che a corte spadroneggia un’accolita di eruditi e artisti, che lei ha raccolto dopo aver vinto la guerra che si chiamerà dei Trent’anni per dare alla ruvida Svezia la cultura che non ha. Già nel primo incontro, però, la regina perde interesse verso il suo insigne invitato, che del resto si presenta a lei con alcune dichiarazioni goffe. René capisce subito che per lei l’importante è averlo aggiunto alla schiera dei suoi eruditi e, peggio, che questi tramano e pettegolano perché si sentono messi in ombra dalla sua formidabile reputazione. Si apre per lui un periodo fatale di solitudine e di chiusura. Lo tengono collegato al suo mondo le lettere che scrive e riceve da tutta Europa, in particolare quelle con la principessa Elisabetta di Boemia, esule dalla sua terra tra Berlino e l’Aia, femme philosophe ben più solida di Cristina e soprattutto sua leale e profonda amica (e di certo, benché castamente, qualcosa di più).
La regina, che in cinque mesi dedica a Descartes non più di quattro o cinque incontri, e sempre all’alba, pur di dargli qualcosa da fare lo incarica prima di redigere lo statuto di un’accademia e poi, addirittura, di scrivere il testo di un balletto per celebrare la vittoria nella guerra dei Trent’anni. Prigioniero impotente, René usa codici dispettosi ma geniali per far capire che non intende stare più al gioco: concepisce lo statuto dell’accademia in modo che sia… preclusa agli stranieri e, non contento, dissemina il testo del balletto di allusioni losche, tutt’altro che intonate allo scopo encomiastico: la scena è infatti attraversata da disertori, traditori, feriti, sciancati…
A questo punto, dopo mesi di isolamento e di silenzio, René, aspettando all’alba, dinanzi al portone del palazzo, di essere ricevuto dalla Regina, stramazza in terra e dopo qualche giorno di malattia muore. La versione ufficiale parla di polmonite; altre ipotesi, anche in noir, sono formulate o adombrate da documenti recenti.
Questa è, a grandi linee, la storia. A me pare bellissima, e mi è parso anche che, non avendola nessuno narrata in modo degno, forse era il mio turno.
Essendo da un pezzo lettore di cose cartesiane, l’avvio mi è stato facile. Ho scoperto subito che la storia era piena di buchi; e su questi – come tutti i restauratori di documenti guasti – ho costruito il mio ruolo. Ciò che ci rimane di quella storia sono narrazioni contenute nel corpo di lettere: ciò ha imposto al mio libro perentoriamente, sin dall’inizio, l’andamento del romanzo epistolare. Però le lacune mi hanno spinto a sviluppare altri tipi testuali: ho allora inventato una varietà di forme per raccontare frammenti diversi di questa storia
Prima invenzione: i diari. Ho inventato un diario di Descartes e uno di madame Chanut (la moglie di fantasia dell’ambasciatore Chanut, che invece è ben reale). Ho inventato resoconti di spie, rapporti di sicofanti e pettegoli. Questa varietà di forme testuali mi ha dato grande soddisfazione: mi ha permesso di non adottare il punto di vista dello scrittore che sa tutta la storia dall’inizio e la distribuisce, la sbriciola, la comunica via via che avanza; ho potuto invece, ad ogni nuovo passaggio, assumere la voce di uno che vede le cose dal suo punto di vista. Ciò mi ha permesso una straordinaria libertà, perché mi ha sollevato dall’obbligo di possedere tutta la storia sin dall’inizio.
Quindi la responsabilità dell’autore ne è stata alleggerita ma al tempo stesso arricchita della possibilità di cambiare punto di vista, come una macchina da presa che ruoti attorno allo stesso oggetto mentre attorno a quell’oggetto ne ruotano anche altre. Libertà formidabile per uno scrittore! E, suppongo, libertà non indifferente anche per il lettore, che ha il vantaggio quasi cinematografico di vedere lo stesso oggetto osservato, fotografato o filmato da più punti di vista, ogni volta trovando o supponendo cose differenti da quelle che gli sono state presentate.
Tra i personaggi, è stata già menzionata la grande Elisabetta di Boemia, principessa coltissima, donna filosofa, amante intellettuale di Descartes, che la contraccambia scrivendole lettere nelle cui formule di chiusura ci sono formulazioni amorose straordinarie nella loro complessità barocca. Elisabetta sa tutto ciò che accade a Stoccolma, ma lo sa sempre in ritardo. Tant’è vero che, nell’ultimo passaggio del romanzo, scrive una lettera a Descartes augurandogli e invitandolo a tornare, perché la sua mancanza è sofferta da tutti, a partire da lei, fa questo non sapendo che Descartes è già morto.
Quanto a Cristina, personaggio storico, per lei ho adoperato una varietà di dati e documenti storici, ma le ho attribuito lettere che non ha mai scritto.
Per riempire i vuoti (René è parco di particolari e Baillet, più tardo di un secolo, banalizza diversi passaggi nell’obiettivo di costruire un profilo eroico del personaggio) ho immaginato nuovi personaggi e eventi. Per esempio un curioso pittore-poeta spagnolo, Machado, che abita dagli Chanut e diventa amico di Descartes, e Cordovero, enigmatico capitano di nave che promette a René un aiuto che non può dargli. Ho costruito le forme fisiche e la mente della signora Chanut, che si innamora del filosofo e lo accudisce con immensa discrezione; una folla di personaggi minori, che popolassero gli spazi vuoti e dessero vibrazione all’insieme. Ho dato una torsione fantastica a una quantità di personaggi veri, a partire dal bibliotecario regio Freinsheim e dal valletto Schlüter, in modo che facessero, oltre alle cose documentate, anche altre cose che aiutassero la narrazione.
Ho immaginato poi un set scenografico e un paesaggio: palazzi, anditi, sale, biblioteche, cataloghi e liste, Wunderkammern, piazze, canali ghiacciati, barche, dettagli, fondali, silenzi, una Stoccolma grigia e freddissima, che si indovina quasi solo per audita… Ho immaginato una vita esterna e una interna: sogni, visioni, allucinazioni. Ho immaginato che René faccia la scoperta di alcune cose che gli erano ignote: l’arte e il ridere (a cui lo inizia Machado), la sensualità e il corpo (a cui, senza accorgersene, lo spinge madame Chanut), l’inganno e la doppiezza (a cui lo rimandano tutti gli altri).
Ho immaginato anche una chiave di tutta la storia, basandomi su un fatto vero. L’ultima opera di René è il trattatello Les passions de l’âme, dedicato a Elisabetta e in parte dovuto alle discussioni avute con lei su quei temi. Le passioni vi sono descritte e classificate con tono sostenuto e con un atteggiamento che diremmo strutturalistico: passioni complesse scomposte in poche passioni semplici, in una geometria non meno coraggiosa che indisponente. Quest’opera ambiziosa e ingenua pretende di ordinare un tema che René non conosce quasi affatto, data la vita che ha fatto, ricca di idee ma povera di passioni! Quasi a riprova di questa “immaturità passionale”, René impernia su questo libretto una sua formidabile gaffe (reale): dopo averlo dedicato a Elisabetta lo ridedica alla regina, ma Elisabetta lo viene a sapere e se ne risente! Questi fatti mi offrivano due dritte cruciali: la storia sarebbe stata dedicata alla scoperta delle passioni “vere”, ben diverse da quelle che classificano gli entomologi; inoltre, l’irresistibile propensione di René alla gaffe mi suggeriva di adottare come chiave la doppiezza, la duplicità, la distanza tra ciò che si dice e ciò che si intende e si ottiene… L’idea di doppiezza, a sua volta, suggeriva una stratificazione del racconto: le cose accadono, qualcuno le riferisce, altri riportano, molti le travisano…
Tra questi personaggi, ho i miei preferiti. Il primo è Machado (che voi, cari amici, avete menzionato poco): si tratta di un pittore che non dipinge, piuttosto scrive versi. È un vero amico di Descartes, ma, essendo un pittore che non dipinge, anche in lui c’è qualcosa che non torna. Però egli ha due responsabilità fondamentali. Anzitutto inizia Descartes alla bellezza dell’arte. Avete sentito poco fa la menzione del quadro di Correggio in cui Giove trasformato in nuvola seduce Io: ebbene, si tratta di un quadro che la regina possedeva realmente, tra le collezioni che aveva sottratto a Rodolfo di Boemia, e Machado fantasticamente porta Descartes a vederlo. Descartes osserva il quadro da vicino, lui che di arte non sa niente, mentre Machado gli spiega tecniche e metodi dell’arte, e in particolare la velatura, con cui i pittori sovrappongono gli strati di pittura l’uno sull’altro. E, con analogia immediata, egli scopre che anche le passioni di cui si sta occupando sono come l’immagine pittorica, perché possono esibire una forma e nasconderne un’altra sotto una velatura. Scopre cioè che le passioni che ha classificato come entità ben riconoscibile sono in effetti realtà complesse e stratificate. Comincia cioè, attraverso quest’avvicinamento all’arte, a percepire che il mondo è sostanzialmente duplicità o (se volete) doppiezza.
Machado inoltre fa ridere Descartes. Come raccontano le fonti, Descartes non sa ridere: è un uomo grave e serio. E Machado cerca di iniziarlo al riso, insegnandogli proverbi spagnoli adatti alle circostanze ma anche forzandolo a leggere dei passi del “Don Chisciotte”. Don Chisciotte aleggia nelle pagine del mio libro (Carillo lo ha visto bene) e in qualche caso Machado nota anche somiglianze nelle situazioni di don Chisciotte e in quelle di Descartes. Don Chisciotte riappare alla fine, in una delle narrazioni della morte di Descartes, quando Machado ne informa la principessa Elisabetta.
Attorno a questi personaggi principali circola una varietà di personaggi minori, alcuni storici, altri di invenzione: il dotto Salmasius (Claude Saumaise), notissimo filologo francese, scopritore dell’Antologia Palatina: persona invidiosa e potentissima, che vede in Descartes una minaccia; il bibliotecario Freinsheim, amico di Descartes, anche se costretto nel suo ruolo a fare una varietà di resoconti spionistici alla regina e al cancelliere Oxenstierna. O anche il vecchio nobile Banér, che cammina sul ghiaccio ad occhi chiusi aiutandosi con un bastone con cui saggia il suolo. Cammina a occhi chiusi, perché, pur vedendo, vuole sperimentare come sarà la morte quando verrà. Poi c’è un personaggio storico, l’abate Viogué, che vive anche lui in casa dell’ambasciatore Chanut, prete turpe e licenzioso che lancia allusioni scurrili alla signora Chanut. Ora, Viogué sospetta che Descartes sia un eretico e che sia andato in Svezia per disturbare la conversione al cattolicesimo che la regina ha maturato (sapete che la regina Cristina si convertì, abbandonò il trono e visse lungamente in Italia, dove morì).
Il punto culminante della narrazione è costituito dalla morte di Descartes. Questa è fatta da quattro punti di vista. Uno è quello della fonte storica principale, la biografia primosettecentesca di Baillet, che accredita la tesi della morte per polmonite. Un altro è la lettera autentica di un medico svedese che, il giorno dopo la morte di Descartes, scrive una vera lettera al suo collega olandese utilizzando una serie di termini tecnici, per fargli capire senza dirlo che Descartes è stato avvelenato. Poi c’è il racconto di Machado, il principale amico di Descartes, che, rivolgendosi a Elisabetta, dice chiaramente che nella morte di quel grande lui vede un assassinio per avvelenamento. L’ultima versione della morte è quella dell’ambasciatore Chanut, che la racconta al re di Francia. In questo modo il romanzo si carica anche di una sfumatura noir: i sospetti si accumulano, i dati di fatto e quelli fantastici si mescolano, la verità dei fatti sembra svaporare tra le congetture e le supposizioni.
Concluderò con due osservazioni. Una riguarda il linguaggio che ho adoperato; l’altra costituisce una sorta di enigma tra i lettori del libro. Quanto al primo punto, avendo io piste già segnate dalla straordinaria prosa di Descartes, il mio sforzo è consistito essenzialmente nel rifare quella prosa. Ciò mi ha naturalmente portato (con fatica, perché è stato un lavoro di grande impegno) a scegliere un linguaggio sostenuto, solenne, importante. Romano Luperini lo ha definito “linguaggio manieristico”. Io non so che cosa significhi, in questo caso, il termine manieristico, ma di certo il linguaggio che ho adoperato è sorvegliato e studiato. Oltre che diventare, a un certo punto, quasi un bisogno per me, questo linguaggio mi ha risolto anche un problema cruciale, che somiglia molto a quello dinanzi al quale si trovava (si parva licet) il grande Alessandro Manzoni. E cioè: quale lingua deve usare uno scrittore che voglia raccontare una storia in italiano? La lingua di ottocento parole degli “scrittori-cannibali” o quella ultraricercata e multidimensionale di Gadda? Io ho trovato la strada di “rifare” la straordinaria lingua della corrispondenza di Descartes.
Seconda osservazione: gli enigmi. Di enigmi (allusioni, citazioni, anacronismi, apocrifi ecc.) ho disseminato il libro. I lettori più accorti se ne avvedranno; gli altri potranno ignorare questo tema. A me come autore, in ogni caso, il lavoro di tessitura di enigmi ha dato grande soddisfazione. Tra questi, uno riguarda la quantità di pagine che ho preso da fonti, di contro a quelle che ho scritto ex novo. Non so se possa interessare saperlo, ma le pagine che ho preso da originali saranno otto o dieci in tutto, rispetto alle trecento del totale di cui si compone il romanzo. Il resto è opera mia.
Concludo dicendo una cosa riguardante la mia esperienza: mi è molto costato far morire Descartes. Mentre la scrittura letteraria conferisce a chi la pratica la più grande libertà (perché prendi i personaggi, li posi su un palcoscenico, li fai muovere, parlare, tacere, avanzare o arretrare come vuoi, secondo il tuo gusto), a un certo momento ti accorgi che (per rifarmi al riferimento al dramma barocco tedesco, che acutamente ha proposto Carillo), se stai parlando del tiranno, godi a farlo soffrire; ma, se stai parlando del martire, sei triste quasi quanto lui nel momento in cui devi dargli la morte.
Valeria Pellecchia Pratelli legge, dal romanzo di Simone, le pagine 294-296
(la morte di Descartes narrata da Machado)
Vincenzo Cutolo ringrazia tutti e dichiara concluso l’incontro culturale.
Intrervista a Raffaele Simone
IL PAESE DEL PRESSAPPOCO
di Maurizio Teroni
Simone (Lecce 1944) è uno dei maggiori studiosi europei di linguistica e filosofia. Membro dal 1967 della Società di Linguistica Italiana (SLI) e dal 1988 della Società Italiana di Glottologia (SIG) e del Cercle Ferdinand de Saussure di Ginevra. Nel 1986 fonda la rivista bimestrale Italiano e oltre, che ha diretto fino alla sua chiusura nel 2004. Dal 1992 è professore ordinario di Linguistica Generale presso l’Università degli studi Roma Tre, dove è anche stato, fino al 2008, Direttore del Dipartimento di Linguistica e Delegato Rettorale per il Progetto Scuola Superiore. Tra le sue opere, ricordiamo: Fondamenti di linguistica, L’università dei tre tradimenti, Idee per il governo dell’università, La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo Il paese del pressappoco, Il mostro mite
Teroni– L’analisi dell’Italia e degli italiani che emerge dal Suo libro Il paese del pressappoco possiede, a mio avviso, un grande merito: un intellettuale di spicco prende in esame la realtà quotidiana con sguardo da cittadino, e non da cattedratico. L’universo culturale italiano, invece, sembra mantenersi sempre distante dalla realtà del quotidiano. Voglio partire proprio da questo assunto per chiederle: perché, secondo Lei, gran parte del mondo intellettuale italiano è così lontano dal mondo dei non intellettuali? Non sono forse anche gli intellettuali responsabili di questo vuoto culturale, così evidente in Italia oggi?
Simone – Non credo che gli intellettuali italiani abbiano responsabilità specifiche. È l’intellettuale in generale, come figura sociale e professionale, che è destinato a restare distante, anche nei casi in cui asserisce la sua prossimità all’interesse del “popolo” o della “gente”. Quel che c’è di specificamente italiano, in questo caso, è la crisi abissale della creatività. Guardata a distanza, l’Italia è un paese che non genera significativi prodotti dell’intelligenza da almeno vent’anni: letteratura, arte, cinema, teatro, architettura, disegno urbano, perfino scienza, sono oggi poco rilevanti o irrilevanti. Praticamente la nostra ricerca del bello e del buono è affidata agli stilisti di moda! Non è poco, ma non basta. Il motivo di questo fatto è oscuro, ma non dubito che il clima politico depresso e volgare in cui viviamo abbia un ruolo.
Terone – Il paese del pressappoco può apparire come un atto di rifiuto e disprezzo verso il proprio Paese, eppure, parallelamente, sembra sorretto da una sorta di passione patriottica. Voglio semplicemente chiederle: cosa l’ha spinto a scrivere un testo del genere?
Simone – Non disprezzo il mio paese, ma non si può dire neanche che lo ami. In effetti, quando ne sono lontano (come in questo momento: sto scrivendo da Parigi), quel che mi manca è – lo confesso – solo il clima e la cucina, imbattibile. Basta uscire dal confine per accorgersi che in Italia appaiono conquiste eccezionali delle cose che altrove sono banali e scontate, dalla pulizia delle città, all’efficienza dei mezzi pubblici, alla decenza delle reti televisive, alla generale buona educazione delle persone, al funzionamento degli ospedali e degli uffici pubblici, alla ragionevolezza dell’amministrazione e del fisco. Mi ha spinto a scrivere il fatto che, essendo viaggiatore, non sopportavo più questo confronto. Perché solo in Italia no? Mi domandavo continuamente. Che abbiamo fatto di male? Questo libro mi ha aiutato a trovare una risposta, e a darla a qualche mio lettore. Comunque, come elemento della risposta, ho trovato anche che a soffrire di quei difetti siamo parecchi, ma non il ceto dirigente, a cui della “differenza italiana” (il pressappoco) non gliene frega assolutamente nulla. Ciò non sorprende, perché nel pressappoco può pescare tranquillamente il potere, piccolo, medio e grande.
Teroni – Cito dal Suo libro: “L’Italia è il paese della solitudine del cittadino, che non si sente protetto e tutelato da nessuno. Chi dovrebbe proteggerlo e tutelarlo lo angaria, chi dovrebbe riconoscerlo lo ignora” Come si può incolpare l’italiano di cinismo, visto che, in Italia, vige la legge del “fregare per non farsi fregare”?
Simone– Ripeto la domanda di prima: Ma perché? Che abbiamo fatto per meritarci questo?
Teroni – Ne Il mostro mite analizza invece la sconfitta e gli errori della Sinistra. Buona parte della crisi attuale italiana è legata a un’evidente incapacità della Sinistra di cogliere le reali istanze del popolo, finendo addirittura per rappresentare il modello di una politica inetta. Forse la Destra ha vinto e vince proprio perché ha saputo offrire una politica di risposte più urgenti e più vicine alla maggioranza degli italiani. Qual è la sua opinione in proposito?
Simone – Non mi pare che la destra abbia offerto alcuna risposta reale, dato che con questa destra non stiamo meglio di prima, anzi. Inoltre, questa destra ha un atteggiamento anti-intellettuale quasi maccartista, che neanche il celebre Scelba aveva nella stessa misura. Gli intellettuali vanno tenuti a bada! Io credo che la sinistra abbia perso (e, temo, continuerà a perdere) per quattro motivi: (a) non riesce a cancellare la traccia sanguinosa del comunismo; (b) si è stinta fino a essere irriconoscibile; (c) la sua dirigenza è litigiosa e mediocre; (d) non riesce a lottare contro il Mostro Mite, del quale non si è neanche accorta. Le ragioni (b) e (c) sono specificamente italiane, le altre sono planetarie, e quindi richiedono un’energia speciale. Il programma è vasto e tremendo, e intanto ci godiamo Berlusconi.
Teroni – L’Italia è chiamata il Bel Paese, ma la realtà è ben diversa: maleducazione, disinteresse verso il prossimo e verso le leggi sembrano farla da padrona. Il paese del pressappoco guarda l’Italia come una nazione in cui prevale una sostanziale irresponsabilità civica. Forse non siamo ancora storicamente abbastanza maturi per una democrazia seria. Non c’è, tutto sommato, il rischio di pensare che il nostro Paese abbia bisogno di un grande padre autoritario, ovvero di un dittatore?
Simone – È proprio a questo che dovevano servire Berlusconi e i suoi amici post-fascisti, nell’opinione di chi lo ha votato. Gli italiani hanno una corda fascista nell’anima (come tutti i popoli che non hanno avuto né borghesia né rivoluzione, ma sono passati dalla miseria al consumismo), ma stavolta hanno sbagliato. La BB (Banda Berlusconi) si è limitata a fare i propri affari e a distruggere le strutture pubbliche (scuola, università, sanità, ecc.).
Teroni – I suoi ultimi libri non prospettano ottimismo per il nostro Paese. Le chiedo semplicemente di esporci, per chiudere, quale futuro vede Lei per l’Italia, se c’è un futuro?
Simone – Spero che i giovani, che viaggiano e confrontano, finalmente capiscano e ci tirino fuori da questa umiliante palude.
(dal sito internet http://www.stradepossibili.it)